Baroncini Nella - 1
Vai alla scheda biografica di
"La vita si è fermata là". Testimonianza di Nella Baroncini edita nel 1961 in raccolta di testimonianze (in archivio ANED Bologna).
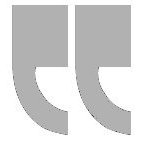 Siamo stati arrestati tutta la famiglia assieme, eravamo in cinque, c’era mio babbo che lavorava in una officina statale ed eravamo tre sorelle e la mamma. Noi si lavorava per i partigiani, avevamo in casa macchine da scrivere, materiale di propaganda più che altro. Lavoravamo tutti. Anche io, che allora avevo diciott’anni, ed ero la più giovane, m’ero proprio messa d’impegno. Sentivamo di dover far questo. Non era perché nostro padre la pensava in un dato modo; siamo state quasi più noi ragazze, anche se eravamo molto giovani, una sorella aveva vent’anni e l’altra ventisei, a voler fare quel poco che eravamo in grado di fare. Non eravamo dentro alla vita politica, non eravamo niente, solo ci sembrava che non si dovesse restar ferme, anche se eravamo donne. Facevamo lavoro di propaganda: battevamo a macchina le matrici per il ciclostile, tiravamo copie e copie di manifesti e li distribuivamo. Avevamo ognuna la nostra zona, mia sorella andava dalla parte di Imola, io dalla parte di Casalecchio; facevamo i nostri giri coi nostri pacchi di manifesti. Allora poi usava la bicicletta, eravamo nell’inverno del ’44. Comunque non abbiamo potuto lavorare per molto tempo perché in febbraio siamo stati arrestati. Mio padre lo prelevarono dall’officina, noi invece ci trovarono tutte in casa. Fu una mattina, ricordo, erano le otto e tre quarti del 24 febbraio 1944, stavamo uscendo per andare in ufficio. Trovarono le macchine da scrivere e alcuni manifesti: materiale vero e proprio no, come liste di nomi, no, per fortuna.
Siamo stati arrestati tutta la famiglia assieme, eravamo in cinque, c’era mio babbo che lavorava in una officina statale ed eravamo tre sorelle e la mamma. Noi si lavorava per i partigiani, avevamo in casa macchine da scrivere, materiale di propaganda più che altro. Lavoravamo tutti. Anche io, che allora avevo diciott’anni, ed ero la più giovane, m’ero proprio messa d’impegno. Sentivamo di dover far questo. Non era perché nostro padre la pensava in un dato modo; siamo state quasi più noi ragazze, anche se eravamo molto giovani, una sorella aveva vent’anni e l’altra ventisei, a voler fare quel poco che eravamo in grado di fare. Non eravamo dentro alla vita politica, non eravamo niente, solo ci sembrava che non si dovesse restar ferme, anche se eravamo donne. Facevamo lavoro di propaganda: battevamo a macchina le matrici per il ciclostile, tiravamo copie e copie di manifesti e li distribuivamo. Avevamo ognuna la nostra zona, mia sorella andava dalla parte di Imola, io dalla parte di Casalecchio; facevamo i nostri giri coi nostri pacchi di manifesti. Allora poi usava la bicicletta, eravamo nell’inverno del ’44. Comunque non abbiamo potuto lavorare per molto tempo perché in febbraio siamo stati arrestati. Mio padre lo prelevarono dall’officina, noi invece ci trovarono tutte in casa. Fu una mattina, ricordo, erano le otto e tre quarti del 24 febbraio 1944, stavamo uscendo per andare in ufficio. Trovarono le macchine da scrivere e alcuni manifesti: materiale vero e proprio no, come liste di nomi, no, per fortuna.
Mio padre e mia sorella furono trattenuti al comando delle SS in via Risorgimento e sottoposti per più di un mese a interrogatori e torture. Noi a San Giovanni in Monte, che è il carcere qui a Bologna. Ai primi di maggio ci trasferirono a Fossoli e così ci ritrovammo e poi vennero le divisioni. Mio padre fu portato via con un gruppo di uomini, noi donne da Fossoli ci portarono direttamente al campo di Ravensbruck, che come campo di donne era il maggiore. Partimmo mi sembra il 2 d’agosto, il 6 eravamo là. Il viaggio fu in carro –bestiame naturalmente, sigillate dentro, pigiate senza poter dormire, ci aprivano alla sera per le nostre necessità.
Come entrammo a Ravensbruck, in questo gran piazzale, ci lasciarono lì per qualche ora in piedi, poi ci chiusero dentro le docce. Poiché cominciavamo a sentir parlare, specialmente dalle ebree, di forni crematori, di docce col gas, rimanemmo molto impressionate, ma per quella volta andò bene. Ci tennero lì dentro chiuse per due giorni.
Intanto cominciavamo a vedere le scene all’esterno, le donne che già da tempo erano al campo, ridotte pelle e ossa. Ci pareva impossibile che a un certo momento saremmo arrivate anche noi a quel punto. Venivano lì, rischiavano botte e bastonate pur di vedere se noi potevamo dare qualcosa da mangiare. Pensavano forse che, arrivando da fuori, qualche rifornimento potevamo averlo. Ci pregavano, scongiuravano, dicevano: “Guardate, vi porteranno via tutto, quello che non riuscite a mangiare non vi conviene tenerlo, non vi serve a niente, non vi lasciano niente”. Abbiamo visto che andavano a cercare nei rifiuti. Siamo arrivate anche noi a farlo, ma in quel momento ci sembrò una depravazione: ci sembrava quasi gente estranea, anormale.
Dopo due giorni, chiuse lì dentro, nelle docce, chi piangeva, chi si disperava, chi cercava di far coraggio alle altre. Poi arrivarono i tedeschi. Ci hanno spogliate, ci hanno fatte passare in rassegna completamente nude. C’erano, tra le ebree, bambinette anche più giovani di me, c’erano persone vecchie o anziane, come poteva essere mia mamma: tutte uguali, non facevano nessuna differenza, infischiandosi dell’umiliazione che potevano dare. Mi parve una cosa terribile. Ci dettero due stracci per vestiti, già portati da altra gente arrivata prima e forse già morta, tutti contrassegnati con grandi croci sul davanti e sul didietro. Alcune furono rapate a zero, quelle che avevano i capelli più belli, e poi ci misero nelle baracche. Eravamo in castelli a tre piani.
Io avevo il numero 49553, lo ricordo ancora, erano numeri progressivi; eravamo sempre una media di trenta - quarantamila donne in quel periodo. Alla fine eravamo molte di più. Nelle cuccette, che erano tre piazze molto ridotte una vicina all’altra, si stava in due per ogni piazza; ognuna dormiva sui piedi dell’altra. In principio, noi della famiglia eravamo riuscite a tutte insieme. Poi, andando avanti, cominciarono a verificarsi certi disturbi che non so, forse per quello che si mangiava, ci si fermarono le mestruazioni; dopo un mese, nessuna di noi, insomma … E da questo altri inconvenienti, sfoghi purulenti, a certune si gonfiavano le gambe, ad altre anche la faccia: io penso per il fermo improvviso del sangue.
Lavorare significava andare alla foresta a segare alberi, andare col badile in spalla a caricare carrelli di sabbia; prendevamo la sabbia da una parte e la trasportavamo in un’altra parte, così, solo per farci lavorare. Scavavamo anche trincee. A sorvegliarci nelle baracche erano le lagerpolizei, sì, le kapò, che quelle erano una razza, purtroppo … Erano delle internate anche loro, ma mentre noi avevamo il triangolo rosso da politiche, quelle erano contrassegnate col triangolo nero da criminali o asociali. Venivano appositamente scelte fra quelle che meglio avrebbero saputo svolgere il loro compito di aguzzine.
Noi italiane eravamo poche, in maggioranza erano polacche internate da anni e anni, francesi, russe, slave, belghe, olandesi. Tra noi poche italiane ci trovammo abbastanza perse, perché non avevamo modo di organizzarci. Negli atri gruppi più numerosi c’era che riusciva i infilarsi, a lavorare nelle cucine o negli spogliatoi, e uscendo potevano portar fuori qualcosa: il nostro gruppo rimase isolato. Di partite da Fossoli eravamo circa quarantacinque.
Poi, cominciammo a dividerci anche noi italiane. Alcune andavano a lavorare fuori nelle sartorie e dormivano anche fuori del campo, altre a una fabbrica, la Siemens. Non che stessero molto meglio di noi, ma lavoravano al coperto. Noi non abbiamo mai cercato di andare in quei posti, cercavamo di stare tutte assieme soprattutto per la mamma. La mamma restava in baracca a far le calze per le comandanti tedesche. Avevo dimenticato di dire che il campo era comandato dalle hauserin, volontarie delle SS. Mi dispiace dirlo perché sono una donna, ma in certe cose le donne sono peggio degli uomini, sinceramente. Ho visto scene addirittura terrificanti: noi tutte mezze nude, spogliate, affamate, malate, ogni tanto qualcuna non ce la faceva più e cadeva in terra, specie le anziane: le abbiamo viste, queste ragazze giovani, accanirsi contro con calci, pugni, che una o moriva lì o se s’alzava era proprio per forza di disperazione. Sì, erano proprio ragazze giovani, quasi tutte.
Il cibo era immangiabile. Noi, in principio, eravamo disperate, ci siam viste portare quelle rape, un mestolo di rape a mezzogiorno, una razioncina di pane molto scarsa – quel pane nero tedesco, ma fatto apposta per i prigionieri, non quello che mangiavano loro. Il pasto della sera era quasi nullo, ci davano a volte quel po’ di rape, quando eravamo fortunate una patata bollita: ricordo che si faceva a pugni per poterla avere un pochino più grande, un pochino meno sbriciolata.
L’unico momento che si stava bene era la notte, perché si sognava, e si sognava di essere a casa. Di essere a casa, o di tornare, o di esserci sempre state. Tra di noi si parlava di piatti, di pranzi, di cene, mi ricordo che abbiamo imparato tante di quelle ricette, perfino la polenta nera fatta coi fagioli. Le scrivevamo, le copiavamo. A qualsiasi ora si facevano i conti: adesso che cosa si potrebbe mangiare, che merenda si potrebbe fare, per oggi che pranzo prepariamo. Sì, i nostri discorsi finivano sempre lì, ma non ce ne annoiavamo mai.
Siamo arrivate là, come ho detto, in agosto, e abbiamo cominciato a parlare delle castagne, dicevamo: “Per il tempo delle castagne saremo a casa”, e allora quelle che abitavano nelle zone di montagna facevano gli inviti per quando saremmo arrivate a casa, ci invitavano a mangiar le castagne. Poi passò il tempo delle castagne e che c’era dopo? Ricordo, eravamo al 15 di dicembre e dicevamo: “Per Natale saremo a casa”, dalla disperazione che avevamo pensando di dover passare l’inverno in quei freddi.
D’inverno ci diedero un paltò, ma sotto avevamo gli stessi stracci e naturalmente quando li lavavamo dovevamo girare col bagnato addosso finché non s’erano asciugati: non si poteva lasciare nulla da nessuna parte perché se si lasciava incustodito uno spillo spariva subito. Col tempo ci si organizzò un pochino, c’era chi riusciva, non so come facesse, ad avere un giubbino, una maglia. Naturalmente, bisognava pagarli: il prezzo era il pane. Un giubbino, ricordo, costava tre razioni di pane, un paio di scarpe costava due razioni di pane, quindi, sa, era pesante. Comunque a un certo momento morir di freddo o morir di fame, bisognava scegliere e fare un grande sacrificio, una fettina tutti i giorni. Eravamo riuscite a tagliare il pane. Quando arrivava, il primo istinto era quello di mangiarlo tutto immediatamente, era talmente piccolo. Riuscimmo a tagliarlo in tante fettine sottili, ma talmente trasparenti che poi alla fine non sentivamo neanche più il sapore.
Poi cominciammo a separarci anche noi dalla famiglia. Cominciammo ad ammalarci. Eravamo in quattro, cominciammo a fare il turno nelle infermerie. Cercavamo di farlo proprio allo stremo, perché si aveva paura. Si parlava di forni crematori e poi, in infermeria, era ancora più terribile. Come ho detto, le italiane erano pochissime, e lì dentro finiva che non ci si capiva più con nessuno. Cominciò prima mia sorella, che si ammalò d’influenza, la chiamavamo influenza. La prima volta che marcai visita io avevo la febbre a più di quaranta. Me la cavai con una settimana di infermeria. Capitai anche bene perché capitai con delle francesi, con le francesi ci si capiva di più, ci si sentiva quasi come di casa nostra. Poi si ammalò l’altra mia sorella, cominciarono col prenderci il posto nella baracca e non potevamo più stare assieme neanche quando tornavamo dall’infermeria. E poi cominciò ad ammalarsi la mamma. La mamma andò avanti parecchio prima di ottenere il ricovero. Non stava in piedi, ma non aveva la febbre e se non si aveva la febbre a quaranta non si era riconosciute come malate. Ricordo, la mattina alle quattro si usciva per fare l’appello. Bisognava stare tre ore impalate, a volte con 18 gradi sotto zero. Gli stracci che avevamo addosso ci si gelavano, ci si gelavano i capelli. La mamma dovevamo portarla fuori a braccia tante volte, perché non stava in piedi. Quando fu ricoverata, dopo una settimana morì.
Noi, la mamma, l’abbiamo vista consumarsi, proprio consumarsi, è morta che non aveva più niente, solo la pelle e le ossa. A rischio di bastonate, andavamo a vederla in infermeria. E avemmo la soddisfazione, chiamiamola pure così, di vederla l’ultima sera. Quando tornavamo da lavorare riuscivamo qualche volta a parlarle da una finestra; poi lei non poteva più alzarsi e con l’aiuto di altre riuscimmo ad andare dentro. L’ultima sera non ci riconobbe nemmen più, ma era calma, tranquilla. E la mattina dopo l’abbiamo trovata già morta in quella cuccia.
Sembra un paradosso dire che è stata una soddisfazione vedere nostra madre morta in quella cuccia lurida e piena di insetti. Quando le detenute morivano, venivano denudate e ammucchiate nella stanza dei lavandini; a sera, ce n’erano delle decine per ogni baracca. Venivano poi caricate, anzi buttate, su dei carretti e quel macabro carico di corpi scheletrici e nudi partiva verso il forno crematorio.
Eravamo rimaste noialtre tre sorelle, c’era la nostra sorella maggiore che era già in infermeria da qualche mese; l’avevano messa nella baracca n.10, la più brutta, l’anticamera del crematorio, così chiamata. Quando riuscivamo ad andare a trovarla, cercavamo di stare più su che si poteva di spirito. Non le abbiamo mai detto che era morta la mamma, perché lei era anche più sensibile di noi. Poi mi ammalai un’altra volta, ricordo che sono andata avanti per più di quindici giorni con febbre alta e una gran tosse. Eravamo già in febbraio del 1945, si cominciava a parlare di forni crematori. Ci mettevano in fila e chi riusciva a stare in piedi la facevano lavorare, chi non resisteva la mandavano nei forni crematori. In quei momenti bisognava appellarsi alle ultime forze per non farsi vedere sfinite. Si sperava sempre nei russi e negli americani. Correvano voci: sono a quaranta chilometri, sono a venti chilometri. Si sperava anche. Cominciavano a parlare di partenze, dovevano evacuare il campo. Io poi non volevo andare in infermeria perché avevo paura di separarmi anche dall’altra mia sorella. E così tiravo ancora avanti. Poi a un certo punto crollai e dovetti andarci.
Dopo due giorni, l’altra mia sorella la fecero partire con molte altre italiane. Rimanemmo nel campo io e mia sorella più grande, tutt’e due in infermeria, una separata dall’altra. Ci siamo scambiate qualche bigliettino, perché era rimasta ancora qualche italiana nel campo. Li conservo ancora, bigliettini scritti su dei pezzetti di giornale, su carta straccia, pieni di spirito proprio. Sapeva che ero ammalata, cercava di far coraggio a me; io cercavo di far coraggio a lei, non le ho mai detto che era morta la mamma. E lei parlava sempre della mamma, del babbo, torneremo a casa, diceva, siamo giovani, ci rifaremo della vita perduta. Ancora adesso vado a rileggerli perché, sì, son cose che per quanto tempo passi rimangono nel sangue. Poi un giorno ci fu una partenza dall’infermeria; lei ci cascò dentro. Non so esattamente che fine abbia fatto, ma dopo alcuni giorni corse voce che quelle che erano partite con quel “trasporto” erano state tutte portate nei forni crematori. Non so convincermi, perché se ha fatto quella fine in quel periodo, l’ha fatta così cosciente; era ancora piena di spirito e di speranza, non era certo in condizioni di non capire. Questo avvenne ai primi di marzo, era una domenica, credo il 4 marzo.
Gli ultimi giorni, quelle che potevano partire le facevano partire. Rimanemmo quasi noi sole delle infermerie, che eravamo tutte destinate ai forni crematori. Ce lo dissero dopo le dottoresse del campo, eravamo nella lista, forse non fecero in tempo. Se avessero potuto, non avrebbero lasciato testimoni. Eravamo talmente inebetite ormai, che si aspettava, si aspettava senza sapere di non potercela più fare, si viveva alla giornata; ogni giorno di diceva: anche oggi è passato.
Una mattina, ricordo che dormivo, sentii un gran trambusto e capii che erano arrivati i russi. Nel momento, ricordo, ci fu una gran gioia. Io ero in infermeria con una slava che parlava molto bene l’italiano perché era stata arrestata in Italia. Lavorava anche lei coi partigiani italiani, quindi eravamo insieme come sorelle. Nel momento abbiamo avuto una gran gioia, poi ci siamo abbracciate e ci siamo messe a piangere tutt’e due: io pensavo che anche andando a casa non avrei trovato più nessuno. Di mio padre non avevamo saputo più niente; ma la vita che facevamo noi, pensavo che mio padre mai avrebbe potuto sopportarla. E forse la sua era stata anche peggiore. L’unica per la quale avevo un po’ di speranza era la sorella partita dal campo.
Di mio padre ho avuto notizie quando sono venuta a casa. Era stato portato a Mauthausen. Ma la vera fine che ha fatto l’ho appresa un anno fa, durante un pellegrinaggio a Mauthausen. Visitammo il cimitero di guerra e trovammo un registro con tutti i nomi dei morti. Ho appreso così che mio padre è morto in un luogo ancor più brutto di Mauthausen, al castello di Harteim. Da quel castello nessuno è uscito vivo, lì i prigionieri erano usati come cavie, per esperimenti. Visitammo anche il castello, era un castello grandissimo. Ho sentito, gli orrori che hanno fatto là dentro nessuno può descriverli. Si vide poi, quando smontarono le attrezzature, attrezzature mostruose, dicevano. Non riuscii a capire di più … In questo castello dove son morte migliaia di persone e anche parecchi italiani, non c’è nemmeno una lapide che ricordi, nulla, il castello è persino abitato. Abbiam trovato qualche notizia scritta a macchina in francese, attaccata a qualche porta dei sotterranei dove dice: qui dove c’erano le più macabre attrezzature oggi è adibito a legna e carbone, per esempio. E poi all’esterno, ma non attaccata al cancello, c’è una lapide francese che ricorda i francesi morti là. Una lapide italiana non l’abbiam trovata. Questa è la fine che ha fatto mio padre.
Alla liberazione, come dicevo, non si stava nemmeno più in piedi. Io non mi pesai, comunque quelle che si erano pesate so che in media erano 28-30 chili. Ricordo solo che nel momento di venir giù dalla cuccia per andare incontro ai russi, tentai di fare un passo di corsa e caddi lunga distesa in terra. Ricordo ancora che, se cadeva qualcosa per terra non era assolutamente possibile raccoglierla. Io e la slava che era con me, un giorno col sole abbiamo provato a uscire dalla baracca; per uscire bisognava scendere un gradino che poteva essere alto come un marciapiedi. Ricorderò sempre, c’era una grondaia, abbiam dovuto aggrapparci a questa grondaia per poter scendere il gradino.
La liberazione del nostro campo avvenne il 30 aprile 1945. Dopo circa un mese i russi portarono noi italiane in un campo dove erano raggruppati militari italiani in attesa di rimpatrio. Ricordo che provai un altro forte dolore in quell’occasione dovendomi separare dalla mia cara Julka, l’amica slava con la quale avevo diviso tanti mesi angosciosi, e ancora più doloroso fu apprendere la sua morte avvenuta poco dopo la mia partenza; purtroppo non riuscì a superare il grave stato di indebolimento in cui si era ridotta. Ci trovavamo nel nord della Germania, e solo nell’ottobre del 1945 potemmo rimpatriare.
All’arrivo, al Brennero, molti scendevano dal treno a raccogliere zolle di terra da baciare. Io fui fermata a Merano come ammalata. Eppoi non avevo il coraggio di arrivare fino a Bologna, sola. Non sapevo che cosa mi aspettava. Mi fermai là e poi scrissi. Scrissi al mio indirizzo di casa con la speranza che qualcuno la ricevesse. Ero proprio disperata quando scrissi quella lettera perché non avevo la minima idea di chi potesse riceverla. Non ebbi risposta, però poco dopo vennero dall’officina dove lavorava mio padre. I suoi compagni di lavoro avevano organizzato questo viaggio per venirmi a prendere.
Naturalmente, per prima cosa, chiesi, ma esitante, chi potevo trovare a casa. Furono loro a dirmi che c’era mia sorella. Era già arrivata da un mese, disperata più di me perché non aveva trovato nessuno. E non mi diedero più nessuna speranza per mio padre; l’avevan già saputo da altri che venivano da Mauthausen. Arrivata a Bologna non andai a casa, incominciai a passare da un convalescenziario all’altro. Allora c’erano i convalescenziari fatti apposta per i reduci partigiani, c’era Villa Altura, c’era il convalescenziario dei Colli e altri. Con mia sorella ci siamo trovate al Belvedere, lì mi raccontò che, prima di sapere mie notizie, dormendo la notte, si alzava gridando il mio nome. Pensava che ero l’unica che potesse tornare.
Per un po’ di tempo abbiamo fatto vita randagia da un convalescenziario all’altro. Non avevamo il coraggio di andare a casa nostra, a pensarla così vuota. Poi, a poco a poco, ci siamo riambientate. Certo, i primi anni sono stati duri. Per anni, le assicuro, mi sembrava di star sveglia di notte e di sognare di giorno: perché di notte sognavo sempre la mia casa e tutta la mia famiglia come’eravamo una volta. Tutte le notti, per anni ho fatto quel sogno. E il giorno si tirava avanti, perché a vent’anni certe cose si riescono a superare. Ma ancora adesso mi sembra che la mia vita si sia fermata là. Sì, si riprende, si va avanti, ma vedo proprio un taglio netto da prima a dopo, ancora adesso sento che manca qualcosa. Noi eravamo una famiglia di operai, molto uniti, non era che in casa mia ci fossero degli screzi o delle liti, si andava molto d’accordo.
Quello a cui non riesco proprio a rassegnarmi è di non aver mai potuto avere notizie precise sulla fine di mia sorella. Ancora oggi mi capita di sognare alla notte di sentire suonare il campanello, e aprendo la porta me la trovo davanti, le parlo, le chiedo come mai torna solo ora …

 BACK
BACK


