Stanghellini Adelio
Vai alla scheda biografica di
Testimonianza di Adelio Stanghellini, scritta nel 1961, da: Luciano Bergonzini, La Resistenza a Bologna. Testimonianze e documenti, Bologna, ISB 1980, vol. V, p. 793
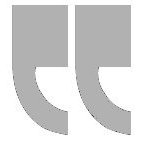 Dopo diversi interrogatori e confronti nel carcere di San Giovanni in Monte, la notte del 22 dicembre 1944, mio figlio Athos ed io partimmo per destinazione ignota, anche se ufficiali delle SS dicevano che saremmo andati a lavorare sul Po. Viaggiammo tutta la notte rinchiusi in camion e vigilati con mitra alla mano. Verso le 5 del mattino ci fermarono in un paesino del mantovano (Pegognaga), ci sistemarono dentro alla scuola elementare e per tutto il giorno ci tennero là rinchiusi, vigilati da uno stuolo di SS e brigate nere. La sera del 23, di nuovo, ripartimmo. Subito dopo dovemmo sostare lunghe ore per attraversare il Po, sul quale era stato costruito un ponte provvisorio con barconi del Genio. Da notare che in quel periodo già molte forze militari erano in ritirata, portando con sé automezzi, bestiame ed altro, depredato il tutto nei paesi circostanti.
Dopo diversi interrogatori e confronti nel carcere di San Giovanni in Monte, la notte del 22 dicembre 1944, mio figlio Athos ed io partimmo per destinazione ignota, anche se ufficiali delle SS dicevano che saremmo andati a lavorare sul Po. Viaggiammo tutta la notte rinchiusi in camion e vigilati con mitra alla mano. Verso le 5 del mattino ci fermarono in un paesino del mantovano (Pegognaga), ci sistemarono dentro alla scuola elementare e per tutto il giorno ci tennero là rinchiusi, vigilati da uno stuolo di SS e brigate nere. La sera del 23, di nuovo, ripartimmo. Subito dopo dovemmo sostare lunghe ore per attraversare il Po, sul quale era stato costruito un ponte provvisorio con barconi del Genio. Da notare che in quel periodo già molte forze militari erano in ritirata, portando con sé automezzi, bestiame ed altro, depredato il tutto nei paesi circostanti.
Il mattino del 24 giungemmo a Bolzano e là ci inviarono subito al campo di concentramento. Appena entrati incominciarono subito la « conta » (ossessione che durerà per tutto il periodo di prigionia), passandoci subito alla rasatura dei capelli; dopo di che ci spedirono in una baracca in muratura e ci sistemarono in una cameretta di strettissime dimensioni (tre metri per due circa e in ognuna dovevano starci venticinque persone, sistemate in castelli a tre piani per dormire in sei ogni castello). Nel pomeriggio fummo radunati sul piazzale del campo e dopo lunga attesa arrivò il comandante del campo coi suoi ordini secchi: «Menschen auf!, Menschen ab!» e cominciava il martirio. Dopo un po' di questo addestramento iniziò la concione del comandante. Di quello che disse mi ricordo soltanto alcuni particolari: uno di questi era che saremmo stati inviati in un «campo di lavoro», altro argomento era quello che chi avesse tentato la fuga sarebbe stato ammazzato sul posto. A conclusione di tutta la concione ci venne detto che «da quel momento non avremmo più avuto un nome e cognome, ma soltanto un numero: "Menschen auf! ", e via».
Durante il periodo che rimanemmo in questo campo non fummo mai impegnati in lavoro né dentro né fuori del campo; solo mio figlio e altri tre o quattro fra i più giovani, furono messi a disposizione di un pilota americano, chiamato Max (prigioniero di guerra), il quale dirigeva lavori per carpenteria nei baraccamenti dietro al campo. Di questo fatto io ne ero contento perché pensavo che ciò servisse a far rimanere Athos in Italia, mentre, invece, dopo pochi giorni tutto finì.
Un fatto impressionante avvenne nel periodo in cui rimanemmo nel campo di Bolzano. La palazzina di fronte al piazzale era adibita a celle di detenzione per pericolosi ribelli; nei primi giorni dell'anno 1945 era stata utilizzata per rinchiudere tre o quattro giovani delle SS a causa di sbornie e litigi. Mentre al mattino andavamo al lavatoio passavamo proprio di fianco alla cella dove era rinchiusa una SS e ogni volta che si passava ci insultava, sputava e si agitava come un energumeno. Un giorno un prigioniero che stava passando, si sentì chiamare ed era proprio l'SS della cella che gli chiedeva se aveva fame, se voleva una pagnotta, in modo che il prigioniero, forse lusingato, si avvicinò alla cella e appena giunto a tiro l'SS, lo prese per il collo e lo strinse alle inferriate fino a strozzarlo.
Il 6 gennaio, verso sera, ci spedirono in camion alla stazione di Bolzano, dove fummo sigillati in carri bestiame: 65 per ogni carro. La fame e la sete che ci accompagnarono in questo vaggio è una cosa indescrivibile; per dare un esempio: per levarci la sete dovevamo leccare le capocchie dei bulloni all'interno del vagone.
Dopo due giorni di viaggio e di lunghe soste, ci aprirono le porte per rifocillarci e ci venne data una scatoletta e una pagnotta da dividersi in due. Dopo questo più niente, fino all'arrivo che avvenne l'I 1 gennaio. Scesi dai vagoni, incolonnati, ci fecero passare per il paese di Mauthausen e arrivammo al campo che si trova su una collina a circa due chilometri dal paese. Il campo si presentò davanti a noi con le sue forme massiccie, ma lugubri, in modo da rendere paura e sconforto, perché esso esprimeva proprio il senso della morte. Dopo una lunga attesa all'interno del campo fummo ammessi al bagno e rasatura. La prima cosa fu quella di spogliarci di tutto, non solo di vestiti, ma anelli, orologi, denaro e tutto ciò che avevamo, poi si passò alla disinfezione ed alla rasatura completa, poi al bagno. Finito il bagno si uscì da un'altra parte dove ci davano un paio di mutande, una camicia e due scarpe rotte, poi fuori al gelo, tra la neve alta.
Condotti nelle baracche, ci rimanemmo per un paio di giorni, poi ci spogliarono e ci consegnarono indumenti vecchi e stracciati e ci portarono dal fotografo dove ci fu dato il numero di matricola.
Il periodo passato al campo di Mauthausen, essendo considerato un periodo di quarantena, eravamo utilizzati alla pulizia del campo. Ogni mattina nella piazza grande dove si svolgeva l'appello assistevamo all'arrivo dei prigionieri carichi di macigni che tornavano dalla «cava della morte». Verso la fine di gennaio, subito dopo passata la mezzanotte, scoppiò un pandemonio dietro al campo dove si trovavano i blocchi di eliminazione: c'era stato un tentativo di fuga. I prigionieri, buttate le coperte sui reticolati e sui fili d'alta tensione, tentavano di scavalcarli, mentre dalle garitte di guardia, con fucili e mitragliette, sparavano in continuazione. Quando fummo chiamati per andare a raccogliere i morti, erano quasi cinquecento.
Il 7 febbraio fummo di nuovo incolonnati e avviati al campo di Gusen II che era un campo di lavoro dove i prigionieri venivano smistati chi per la cava dei sassi, chi per l'officina che si trovava in una galleria nei pressi di San Georg, a cinque chilometri da Gusen; ogni mattina per andare all'officina « Messerschmitt » ci caricavano su un trenino che percorreva il tragitto a passo d'uomo, affinchè le guardie ed i cani potessero seguirci a piedi fiancheggiando il treno. Ogni mattina era una tragedia perché i prigionieri erano molti ed i vagoni erano pochi e quindi bisognava stringersi e al fine di ottenere lo scopo le SS tiravano delle grandi sventagliate di «gomma» (cavo elettrico che adoperavano per bastonarci). La vita interna nel campo di Gusen si svolgeva in dodici ore lavorative, più altre cinquesei ore fra viaggio e diverse «conte», in modo che alla fine si aggiungeva il sonno e la stanchezza. Gli elementi che creavano maggiore decimazione fra i prigionieri erano connessi alla dissenteria.
Alla metà di aprile del 1945 mio figlio Athos si trovò proprio in condizioni disastrose, prodotte da una forte gonfiatura alle gambe: a stento riusciva a mantenersi in piedi, e per questo fu costretto a farsi ricoverare ali'infermeria che si trovava al blocco 13. Gli ammalati sostavano per tre giorni poi sarebbero stati trasferiti al blocco n. 16; da questo blocco era molto difficile tornare perché quello era il « blocco di eliminazione ». Noi prigionieri non conoscevamo la fine che si faceva al blocco 16, ma una cosa era certa e cioè che da quel blocco non tornava nessuno. Fu appunto dopo quattro o cinque giorni che Athos era ricoverato che io decisi di farmi ricoverare per andare a vedere dov'era mio figlio. In questo ne fui favorito dal fatto che io parlavo il tedesco e così mi fu facile convincere il dottore. Giunto all'infermeria del blocco 13, con ansia andai a controllare in tutte le cuccette dei castelli, ma mio figlio non c'era più. Non ci stetti a pensare molto. Dopo un paio di giorni mi feci trasferire al blocco 16 dove trovai mio figlio sdraiato in una cuccetta, a metà della baracca. Da quando lo avevo lasciato era molto peggiorato ed inoltre molto sfiduciato. Restammo due o tre giorni assieme e poi, una notte, un guardiano lo venne a chiamare. Io ero preoccupato, sapendo il posto in cui mi trovavo e vedendo che il tempo passava e mio figlio non si vedeva tornare. Verso mattina vidi un'ombra avvicinarsi brancolando, mi feci avanti e vidi che era Athos: aveva il collo più grosso della testa, il viso tutto sformato.
Io ne fui sconvolto (e questa impressione mi rimarrà per tutta la vita). Con gran fatica riuscì a spiegarmi che quando fu chiamato si sentì arrivare una forte bastonata dietro alla nuca, svenne, si svegliò al mattino, nudo, in mezzo ad una distesa di cadaveri, si rialzò e carponi tornò di nascosto in baracca. Passò il giorno e quando arrivammo a sera di nuovo lo chiamarono e mai più lo rividi. Io ero ormai sfinito e avrei avuto ancora pochi giorni da contare, ma un giorno arrivò l'ordine di sgombrare il blocco 16 e rinviare i prigionieri alle loro baracche (seppi poi che doveva esserci una visita della Croce Rossa). Giunto in baracca mi accasciai nella cuccetta dove già dormivo con un giovane di Bologna. Lui non c'era perché era di turno all'officina. Mi addormentai. Ad un tratto mi svegliai e sentii lontanamente uno che mi strapazzava, mi insultava, mi voleva cacciare dalla cuccetta: era il ragazzo che tornava dal lavoro e non mi aveva riconosciuto. Quando, finalmente, mi conobbe si mise a piangere e voleva sapere dov'ero stato, cosa avevo fatto, cos'era successo. Allora spiegai tutta la mia tragedia, poi dissi che fra poco anch'io avrei seguito Athos e così tutto sarebbe finito. Ero quasi nudo, avevo appena un paio di sottili mutande e una camiciola con maniche corte. Tremavo, non so se era il freddo, la fame o l'impressionante tragedia che avevo passato; forse tutto assieme. Sta di fatto che il ragazzo, vedendomi tremare a quel modo, si tolse le sue mutande lunghe e felpate, me le mise, poi mi coprì per bene e venne a dormire vicino a me in modo da riscaldarmi, e così passammo la notte. Il mattino seguente stavo un po' meglio e mi fecero riprendere subito il lavoro e ricominciò così piano piano la vita del «campo».
Verso la fine di aprile con un gruppetto di bolognesi decidemmo di tentare una fuga; pensammo che morire sfiniti nel campo o morire ammazzati per scappare era la stessa cosa. Incominciammo a pensare come fare, dove e quando. Oppressi da questo pensiero, un giorno mi capitò di parlare con un capo reparto (che forse era un civile, un buon uomo) con cui avevo una certa confidenza. Allora a lui sembrò che fossimo pazzi e lasciò andare la cosa. Il giorno dopo mi fermò, mi disse che lui sarebbe stato disposto ad aiutarci purché l'avessimo portato con noi in Italia. La cosa era buona ed io ne parlai agli altri. Dopo un primo momento di diffidenza e di paura di essere traditi, decidemmo di metterci nelle sue mani. Passavano i giorni, ma questi mi diceva sempre di avere pazienza che avrebbe al più presto provveduto. L'attesa ci manteneva sulle spine ed ogni giorno le nostre condizioni peggioravano sempre più. Infine decidemmo di andare avanti nella cosa per conto nostro. Un giorno della fine d'aprile incontrai di nuovo il capo reparto e lo misi al corrente della nostra decisione; lui mi disse di non commettere pazzie, perché entro sei-sette giorni saremmo stati liberati. E questa fu la verità. Il 6 maggio 1945 giunsero le forze americane.
Dopo venti giorni di peripezie che sarebbe troppo lungo da riportare, raggiunsi Bologna assieme al ragazzo bolognese. Rifocillatomi si poneva il grave problema di presentarmi a casa senza mio figlio. Questa idea mi faceva impazzire, non volevo più andare a casa, volevo scappare, andare via, non vedere più nessuno. Furono i familiari del ragazzo che mi convinsero e si adoperarono per portarmi a casa; infatti mi affidarono ad un compagno partigiano, che si impegnò di portarmi con un cavallo fino a San Giorgio di Piano dove allora abitavo. Giunto sul cancello di casa incontrai mia moglie, mi guardò e proseguì per la sua strada perché non mi aveva riconosciuto. Oppresso dalla paura di dire in famiglia che avevo perso il figlio, non ebbi il coraggio di dirle niente. Stavo per andare via quando il compagno partigiano mi prese sottobraccio e mi accompagnò in casa.

 BACK
BACK

