Manganelli Augusto
Vai alla scheda biografica di
Testimonianza di Augusto Manganelli, da: Renato Bergonzini, La Resistenza a Bologna – Testimonianze e documenti, Volume V, Istituto per la Storia di Bologna, 1980, pag. 787
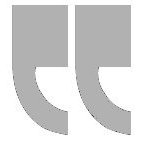 Nel settembre 1943 ero militare a Piacenza. Con l'armistizio scappai a casa. Dopo mi giunse la cartolina per la chiamata di nuovo alle armi, ma riuscii a non andarci iscrivendomi alla « Todt volante » di Cento di Ferrara: nostro compito era di fare degli interventi di emergenza nelle linee ferroviarie, dopo i bombardamenti. Restai nella « Todt » fino all'agosto 1944, quando sempre più insistente cresceva la «voce» che ci avrebbero trasferiti a Verona e poi in Germania. Allora mi assentai dal lavoro e, a casa mia, tramite i miei fratelli già organizzati con i partigiani, entrai nel movimento e partecipai a qualche azione.
Nel settembre 1943 ero militare a Piacenza. Con l'armistizio scappai a casa. Dopo mi giunse la cartolina per la chiamata di nuovo alle armi, ma riuscii a non andarci iscrivendomi alla « Todt volante » di Cento di Ferrara: nostro compito era di fare degli interventi di emergenza nelle linee ferroviarie, dopo i bombardamenti. Restai nella « Todt » fino all'agosto 1944, quando sempre più insistente cresceva la «voce» che ci avrebbero trasferiti a Verona e poi in Germania. Allora mi assentai dal lavoro e, a casa mia, tramite i miei fratelli già organizzati con i partigiani, entrai nel movimento e partecipai a qualche azione.
Con il rastrellamento del 5 dicembre 1944 venni preso in casa mia, assieme ai miei fratelli e mio padre. Mio fratello Gino, insieme a Gino Alberti, lo portarono via subito (mio fratello riuscì a scappare) mentre noi, io compreso, citennero chiusi in casa fino a mezzogiorno. Poi ci portarono al forno di Amola e di qui alla Chiesa.
In sagrestia ci tolsero tutti i documenti e i portafogli e poi ci caricarono su un camion e ci portarono al teatro Comunale di Sant'Agata bolognese. Passai anch'io in fila di fronte ad Hans e venni messo fra quelli da trattenere. Ci misero con la faccia contro il muro e poi un tedesco ci fece una croce sulla schiena con un pennello e vernice bianca. Ci sorvegliavano con una mitragliatrice sul palcoscenico e dei cani poliziotto che ci mordevano le gambe, appena ci muovevamo.
Venni trasferito a Bologna con il secondo gruppo il giorno 8 dicembre, dopo aver trascorso giorni e notti legati come eravamo tutti insieme e senza mangiare. Sia prima, a Santa Chiara, sia dopo, a San Giovanni in Monte, mi interrogarono (in tutto tre volte). Mi dicevano: « Tu conoscere Brunello, tu sapere dov'è, devi dire ». Naturalmente questo a suon di forti schiaffi e pugni e per oltre mezz'ora. Io ho sempre detto che non sapevo nulla.
Il 23 dicembre 1944, per molti di noi rastrellati fu un giorno da non dimenticare mai. Infatti, una parte venne lasciata libera (specie i vecchi, fra cui anche mio padre), molti furono trattenuti e poi fucilati ai colli di Paderno, e altri - e fra questi c'ero anch'io - vennero inviati in Germania. Quando giunse la sera ci chiamarono fuori e, con pedate nel sedere e spintoni, ci fecero salire dentro a sei camion. Eravamo talmente fitti che non ci si poteva muovere. Ricordo che c'erano anche altri, di altre zone di Persiceto (fra cui Franchini di Le Budrie), di Anzola e di Bologna. Tutta la notte girammo, ma non riuscimmo a passare il Po nella notte, cioè quando era meno pericoloso per le incursioni aeree.
Ci scaricarono nelle scuole di un paesino a una decina di chilometri dal ponte di barche di Ostiglia. Ci diedero un pezzo di pane nero e basta. In quell'occasione facemmo vera conoscenza di uno che avevamo fra noi: l'avv. Mario Costa di Bologna, che era molto malconcio, restava appartato e generava in noi sospetti. Rimasi poi sempre con lui, anche nel campo di concentramento, quasi fino alla fine.
La sera tornammo a partire e il mattino all'alba arrivammo a Bolzano. Ci scaricarono vicino al campo di concentramento. Comprendemmo che si trattava di un campo di prigionia vedendo i reticolati e la gente inquadrata e vigilata dai tedeschi. Ci misero dentro dividendoci, naturalmente, dalle donne che avevamo anche nel nostro camion e che erano tre. Il 25 dicembre ci fecero andare tutti a messa nel campo, attorno a un grande albero di Natale.
Le donne le fecero subito lavorare, mentre noi restavamo nelle baracche. Ci davano poco da mangiare e le donne, al ritorno dal lavoro, la sera, ci portavano quello che erano riusciti a racimolare, in genere patate.
Rimasi in quel campo fino al 6 gennaio 1945, quando i tedeschi dissero di prepararci per il «transport-kolonna». Ci svegliarono al mattino mólto presto e ci misero inquadrati nel campo, dove ci fecero restare per alcune ore, con un gran freddo. Poi ci portarono in stazione e ci caricarono in treno, in vagoni bestiame. Eravamo molto fitti, che non si sapeva dove e come stare. Ci diedero una mezza pagnotta di pane nero e basta.
Dopo due giorni e due notti — senza mai aprire il vagone — giungemmo alla fine del nostro viaggio in treno: però non eravamo ancora a destinazione. Ci incolonnarono e, incalzandoci a calci nel sedere, ci fecero salire a piedi la collina che distava circa otto chilometri dalla stazione ferroviaria e sulla quale c'era il campo di concentramento di Mauthausen. Qui ci misero nei « blocchi », cioè nelle baracche numerate (io ero al n. 13). Doveva essere il periodo cosidetto di « quarantena» nel quale eravamo ancora tutti insieme, sempre rinchiusi nella baracca e nel quale facevano tutte le operazioni di « disinfezione »: ci tolsero infatti i nostri vestiti e ci diedero quelli a righe da prigionieri, numerati.
Io avevo il n. 115588; ci rasarono tutti i peli (con rasoi che non tagliavano e che scorticavano la pelle); ci fecero un giro con la macchina per capelli nel mezzo della testa (e ogni settimana ci passavano con il rasoio) perché ciò rendesse possibile individuare un prigioniero del campo di concentramento se fosse scappato e visto all'esterno.
La sera quando ci si doveva coricare in terra su un poco di paglia (piena di pidocchi) era una tragedia. Ci facevano mettere in fila, con la faccia contro il muro, poi al loro ordine dovevamo metterci a terra, sdraiati. Ma eravamo talmente fitti che tutti non si riusciva a starci e allora vi era sempre chi rimaneva in piedi e vi erano sempre delle lotte per potersi coricare. Si pensi anche che eravamo non solo italiani, ma ce n'erano di molte nazionalità. Quando uno aveva bisogno di andare al gabinetto era un orrore perché doveva per forza pestare qualcuno e generare un gran chiasso. Così il capo-blocco, il tedesco che dormiva nella baracca, interveniva. A volte apriva tutte le finestre e ci faceva gelare dal freddo. Altre volte, quando era mattina, faceva uscire tutti inquadrati e fuori ci faceva restare per ore e ore in piedi fermi, a subire il forte freddo.
Ricordo che una delle prime notti che eravamo nel campo, suonò l'allarme. Si sentì un enorme fracasso: sparatorie, abbaiare dei cani, urla dei tedeschi. Noi pensavamo che ci ammazzassero tutti. Finalmente giunse il mattino. Ci fecero uscire e si presentò ai nostri occhi una scena tremenda. Contro il filo spinato nel quale c'era la corrente, e che era stato tagliato, vi era un cumulo di morti. Erano tedeschi che, si disse, erano antinazisti e avevano tentato di scappare.
Ci fecero prendere dei carri e poi svestire i cadaveri e caricarli. Quindi spingere i carri fino contro il forno crematorio. Poi i due che erano sopra il carro gettarono a terra i cadaveri, che erano gelati, perciò facevano un rumore come di fascine di legna; altri li prendevano e li mettevano su uno scivolo che andava al forno. Dentro poi c'erano altri uomini che li buttavano nel forno. Anch'io dovetti partecipare a tale macabra operazione superando naturalmente ogni stato d'animo: si pensi che a casa non ero mai stato capace di rendere omaggio a un morto, per non vedere una salma.
Dopo circa una ventina di giorni cominciammo a lavorare e ci spostarono in altre baracche, più all'interno del campo. Io, ricordo, ero nella baracca n. 18. Ci facevano alzare alle quattro del mattino. Ci si lavava un poco e poi si riceveva un goccio di brodaglia nera che doveva essere caffè. Poi ci facevano uscire nel cortile dove procedevano all'appello. Quindi andavamo a lavorare nella fabbrica di armi « Stayr » che era incorporata nel campo. Nel passare il cancello che divideva comunque il campo della fabbrica avveniva un altro controllo: dovevamo stare assolutamente affiancati in cinque, e loro contavano le cinquine.
Nella fabbrica si lavorava e vi si rimaneva tutto il giorno. Si cominciava alle 7, si faceva un intervallo dalle 12 alle 13 e si terminava alle 18: in tutto dieci ore di lavoro. A mezzogiorno ci portavano una zuppa di rape. Quando capitava che nella coda per il rancio succedeva qualche discussione o scompiglio, arrivava un tedesco con una sbarra di ferro e colpiva a casaccio; quello che ci andava di mezzo, in genere, non si rialzava più. Per tutti gli altri questo voleva dire non ricevere più la sbobba di rape.
Io lavoravo all'esterno, assieme a mio fratello Giovanni, allo scarico e carico del materiale per ferrovia. Si lavorava naturalmente con qualsiasi tempo. Ognuno si arrangiava per cercare stracci e ogni cosa per coprirsi, perché non ci davano nulla di adatto al lavoro. Un giorno mio fratello invece lavorava al coperto e con la stagione andava meglio. Nell'intervallo del pranzo io e Giovanni andammo da Giorgio, a parlare con il suo capo perché sembrava che avessero bisogno di operai nel suo reparto. Ma non ottenemmo nulla, solo che all'uscita del capannone ci vide il nostro capo, il quale infierì contro di me con un forte pugno alla mascella destra e fui costretto a farmi medicare in infcrmeria. Non si trattò di cosa da poco, dato che si era già molto deboli. Si era rotta la carne contro i denti ed era subentrata un'infezione. Così dovetti restare in inferrmeria (luogo questo assai pericoloso, una specie di anticamera della morte), per le cure necessarie, che si protrassero per una decina di giorni e fortunatamente mi salvai. Il mangiare era lo stesso di quelli che lavoravano, ma si aveva il vantaggio di stare al caldo, a letto, e non di lavorare al freddo.
Ciascuno doveva lavorare in genere da solo: cioè un pezzo che fosse alla portata di un uomo doveva essere caricato e scaricato da uno solo e non in due. Col passare dei giorni il fisico cedeva e non era possibile continuare con la stessa misura. Ma i tedeschi non volevano che si lavorasse in due e allora molti cadevano sotto il peso delle casse, o blocchi di ferro. Se uno ce la faceva allora si rialzava e procedeva come poteva, fra calci e colpi dei tedeschi. Nessuno poteva mai aiutare un altro. La sera cominciava una nuova tragedia. Si rientrava con i soliti controlli e appelli e poi ci davano una pagnotta di un chilo da dividerci noi stessi in dieci, e un pezzette di margarina, o marmellata, a testa. Naturalmente nel riparto di quella miseria non sempre le cose andavano a buon fine. Allora avvenivano liti e i più forti mangiavano e gli altri no.
Io non ho mai trovato qualcuno che avesse qualche premura o cercasse di aiutarmi. In genere noi non eravamo visti bene: i francesi ce l'avevano con noi perché li avevamo attaccati, i tedeschi perché ci consideravano traditori e gli antifascisti perché ci vedevano come dei fascisti. Anche per questi fatti la vita nel campo era tutto un crescente martirio.
La notte non volevano che si dormisse con dei vestiti addosso. Bisognava levarseli. Quando uno non si sentiva bene cercava di tenersi più caldo con qualche indumento. Quando aveva bisogno di andare al gabinetto, che distava duecento metri, si vestiva e al rientro aveva freddo e così era tentato di coricarsi con qualche panno addosso. In tal caso poteva essere scoperto e preso a botte fino a morire, o finire così mal messo che in qualche giorno se ne andava.
Dovevamo dormire assolutamente nudi due volte al mese, quando ci facevano la disinfezione. Se pensiamo che nei pagliericci dei castelli di legno non c'era quasi paglia (non veniva mai cambiata) si può meglio capire che ciò contribuiva anche ad aggravare il nostro stato di salute. Due volte al mese pure c'era il bagno. Ci facevano svestire in baracca e poi fare nudi i duecento metri che distavano dalle doccie, con qualsiasi tempo e temperatura. L'acqua era fredda e nel grande camerone, dove c'erano le docce, vigilavano le « SS », con una gomma ripiena. Noi, per non bagnarci, cercavamo di stare contro il muro e allora i tedeschi ci colpivano con tale gomma con il pericolo di finire in infcrmeria, e poi non si sa dove. Chi era preso di mira da qualche capo doveva stare molto attento; ma purtroppo quando ciò capitava si può dire che la sorte era segnata e la vita era già sul punto di finire. Vi era chi borbottava o tentava di spiegare, o scusarsi, dietro le grida e gli insulti di un tedesco. Ciò produceva un esito contrario ed era la fine. Bisognava stare zitti, sempre zitti, per cercare di sfuggire in questo modo alla particolare e costante furia che veniva usata su chi era preso di mira.
Così diminuiva sempre la capacità fisica, aumentava la tensione e la ricerca di qualsiasi cosa da mangiare. Ci dicevamo a vicenda di tenere su il morale e poi sempre più si pietrificava la nostra mente. Stavamo dei giorni e delle settimane senza parlare perché si sapeva che parlare era peggio: si finiva subito sulle cose da mangiare e sul destino. Ognuno si chiudeva in sé, cercava di reagire come poteva.
Iniziammo a mangiare persino del carbone, perché si diceva che poteva contare qualcosa. Scegliemmo i pezzetti migliori. Così pure, all'inizio della primavera, cominciammo a cercare delle erbe che erano appena spuntate. Nel viaggio dalla baracca al luogo di lavoro, e viceversa, poteva capitare di vedere delle bucce di patate nei mucchi del patume delle famiglie tedesche che abitavano e lavoravano nel campo. Qualcuno che non resisteva alla tentazione correva a prenderle. Giungeva allora un tedesco che colpiva con la cassa del fucile, con calci, e ciò è stata certamente la fine per molti.
Si era così creato anche un « mercato » fra i prigionieri per lo scambio di generi, che era però fortemente contrastato dai tedeschi. Vi era chi offriva un pezzetto di pane, o di margarina, o marmellata, per una o due sigarette (ce ne davano due alla domenica); teneva il pezzetto di pane in vista su un foglio di carta, per non perdere delle briciole. Vi era chi faceva sigarette con dei fondi di caffè, ottenuti colando il caffè avuto al mattino con un pezzetto di stoffa.
Praticamente non vi era alcuna possibilità di scrivere perché continuamente ogni giorno venivamo perquisiti più volte. Dopo un mese i primi cominciarono a cedere, poi in seguito il numero di questi cresceva sempre ogni giorno. Noi comunque non abbiamo mai visto alcuno morire. Così come io stesso non ho mai visto mio fratello Giovanni quando è deceduto, anche se lavoravamo insieme. La sua fine è avvenuta dal 20 al 25 aprile 1945. Quando uno non reggeva più veniva portato in infcrmeria e in genere di lui nessuno sapeva più niente. Ciò vuoi dire che tutto era organizzato in modo tale che all'infermeria avveniva la « scelta » e di qui partiva una via nascosta per il crematorio.
Negli ultimi due mesi d'internamento più volte al giorno fu suonato l'allarme aereo. Allora dovevamo fare circa un chilometro di strada per arrivare al rifugio, che era in una galleria sotto la montagna. E ce lo facevano fare di corsa, perché se fosse dipeso da noi, molto probabilmente non avremmo fatto quella fatica (sia per lo stato fisico, che morale).
Ai lati della strada c'erano i tedeschi e nessuno poteva fermarsi. Chi cadeva era finito, perché veniva calpestato dagli altri in corsa, o colpito col calcio dei fucili. Giunti alla galleria si sperava sempre di poterci riposare dalla corsa e dal lavoro e quindi invocavamo un allarme lungo. A volte, invece, ci eravamo appena fermati che suonava il cessato allarme. Allora i tedeschi cominciavano a gridare come bestie: « Fertig, alarm; arbeit! » Allora si usciva, ci si metteva in fila e, inquadrati, ci contavano e poi si partiva. Giunti sul posto, prima di iniziare a lavorare, facevano l'appello. Una volta che non quadrava il conto restammo in piedi inquadrati tutto il pomeriggio, intanto che contavano e ricontavano. Non so poi se qualcuno fosse scappato, ma non credo, o se c'era qualche errore nei registri e nei « passaggi » per l'infermeria, o altro.
La domenica non si lavorava, però la sveglia e tutti i controlli erano gli stessi. Poteva considerarsi il giorno di pulizia. Ci aggiustavamo un poco gli stracci e i vestiti, gli zoccoli di legno. Attaccavamo i bottoni con del filo di ferro. In primavera ci mettevamo seduti al sole contro la baracca, così si muovevano i pidocchi e li uccidevamo. Sopra di noi avevamo sempre dei branchi di cornacchie che gracchiavano e rendevano più cupo ogni momento perché in ogni istante ti rinnovavano il pensiero della crudele fine.
Penso che se fosse continuato ancora per qualche tempo saremmo morti in migliaia al giorno perché eravamo così sfiniti che non ci si reggeva più. Io sono stato più volte in infcrmeria. L'ultima fu due o tre giorni prima della fuga dei tedeschi e cinque o sei giorni prima della liberazione, avvenuta il 5 maggio 1945, ad opera degli americani. In quella occasione salutai mio fratello Giorgio, che continuava a lavorare nella fabbrica. Entrai perché ero sfinito e se non fosse venuta la liberazione certamente era già segnata la mia fine.
In quegli ultimi giorni i tedeschi ammazzarono anche più di prima. E non facevano nemmeno in tempo a bruciare i cadaveri. Poi scapparono, ma gli alleati non giunsero subito. Infatti rimanemmo tre giorni senza alcun aiuto. All'esterno si sentiva un enorme frastuono. Erano prigionieri che cercavano da mangiare e invocavano aiuto. Quelli che potevano muoversi uscirono dal campo e andarono dai contadini per cercare qualcosa da mangiare. Io ero a letto sfinito e immobile. Il castello dove ero coricato era formato da un'unica base in legno, come era lunga la baracca, e ci si metteva uno di fianco all'altro.
Una di quelle mattine quando mi svegliai mi accorsi che non avevo le forze per muovermi. Guardando attorno compresi che nella notte erano morti i due che avevo di fianco: un cecoslovacco e un francese. Fui costretto a restare così com'ero finché non vennero a prendermi. In seguito mi sono convinto che è stata una grande fortuna essere in quei giorni in infcrmeria e non fuori perché, ridotto com'ero, non rai sarei sicuramente salvato. I primi soldati ad entrare furono i francesi che erano con gli americani. Bruciarono tutto, escluso il comando, dove sistemarono quelli ancora vivi. Ci disinfettarono e poi gli addetti ai reparti sanitari cominciarono a curarci. Però non avevamo nessuno che potesse fare da interprete e ciò era un problema serio. Io avevo una tosse enorme. Mi fecero i raggi e poi dopo a un certo tempo mi misero nel reparto di quelli deperiti organicamente. Ricordo che mi facevano sei punture al giorno e altre cure. Eravamo tutti così affamati che mangiavamo il più possibile e quando ci rimaneva qualcosa lo nascondevamo, non lo restituivamo. Una volta feci una forte mangiata che mi procurò non lievi difficoltà.
Mentre ero sotto cura chiedevo continuamente agli altri prigionieri notizie di mio fratello Giorgio. Tra i tanti uno mi disse che era stato visto morto e che era deceduto quando già erano giunti gli alleati. Penso però che la cosa sia improbabile e ritengo che sia stato ucciso nella furia degli ultimi tre giorni di dominio dei tedeschi, quando volevano eliminare il più possibile di gente per togliere ogni possibilità di viva testimonianza dei loro orrori e quindi non si curavano più di distruggere i corpi. Potrebbe anche darsi che in quei giorni fosse solo stato ferito mortalmente e poi deceduto dopo qualche giorno. (Gli americani provvidero a seppellire tutti i corpi dei prigionieri deceduti, e così in seguito abbiamo potuto riportare in Italia le sue spoglie). Mentre proseguiva la cura di quelli che erano rimasti vivi, vennero trasmesse notizie ai familiari. Purtroppo lo scompiglio era tale che a casa mia giunse la notizia che era salvo solo Giorgio e non io.
Noi venivamo curati al massimo delle possibilità, ciò che certamente era molto impegnativo per gli americani. Verso la metà di giugno cominciarono a predisporre per le partenze. Tutti avremmo voluto partire per andare a casa. Ma invece la scelta avveniva certamente in base alle condizioni fisiche dei prigionieri e a eventuali disponibilità o meno dei mezzi necessari. Non fui incluso nel primo scaglione, e come me tanti altri, e provai una delusione così forte che non saprei descrivere. Dopo circa una settimana ci fu il secondo scaglione ed io vi fui incluso.
Sarà stato verso il 24 o 25 giungo 1945. Con autocarri dell'esercito ci trasportarono fino a Linz, in Austria. Qui ci fermammo tutto un pomeriggio e la notte e con me c'era un certo Zambelli, di Sant'Agata, che non ho mai più rivisto. Egli ripartì prima e si impegnò di avvisare i miei familiari che ero in arrivo. Ciò che fece, se pure non direttamente. Da Linz, in treno, partimmo per il Brennero, dove di nuovo ci fermammo e ripartimmo con dei camions. Giunti a Verona ci sottoposero a una visita medica, ci diedero da mangiare e poi il giorno seguente facemmo, sempre con automezzi, il tratto Verona-Modena di notte e poi ci portarono a Bologna, in un campo di smistamento.
Discutemmo molto perché non ci volevano portare a casa, dicendo — cosa incredibile! — che si consumava della benzina. Poi, finalmente, con un « Dodge » cominciarono a portarci a casa. Io fui caricato con uno di Castenaso e uno di Anzola. A Castenaso i familiari non riconobbero il loro caro tanto era ancora mal ridotto.
Quando arrivammo a Persiceto volevano scaricarmi nel capoluogo, anziché portarmi a casa, in frazione di Amola. Dovetti bisticciare a lungo e poi la spuntai. Giunsi a casa il 29 giuno 1945 alle ore 18. Non andai direttamente a casa, ma alla trattoria e bottega del luogo. Ero in pantaloncini corti, con una maglietta rotta, e così magro che a tanti feci paura. Qualcuno avvisò i miei che poi vennero alla bottega. Incominciò poi il peggio. Avevo sempre desiderato di arrivare a casa, ma quando vi giunsi iniziò un periodo tremendo che durò fino alla fine dell'anno. Era continua la fila di gente di Amola e altrove che veniva e voleva sapere chi avevo visto, mi chiedeva notizie e particolari dei familiari. Era una piaga che ogni giorno si riapriva e approfondiva e che solo con il tempo potei rimarginare. Sono rimasti naturalmente impressi per sempre in me tutti questi orrori.

 BACK
BACK

