Badiali Luigia
Vai alla scheda biografica di
Testimonianza di Luigia Badiali, da: Luciano Bergonzini, La Resistenza a Bologna. Testimonianze e documenti, Bologna, ISB 1980, vol. V, p. 799
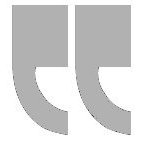 Prima ancora della caduta del fascismo io ero già attiva nelle organizzazioni della Resistenza e quando venne il momento della lotta armata io allora, che ero operaia nella fabbrica per candele d'aerei « Baroncini », situata alle Roveri, abbandonai il lavoro e così fece pure mio fratello Sandro (Thomas) per passare all'organizzazione partigiana. Mio fratello andò coi primi partigiani nel Veneto e io divenni staffetta. Mio compito fu quello di assicurare i collegamenti fra il centro del partito comunista e le varie « basi ». Il lavoro era difficile e molto rischioso.
Prima ancora della caduta del fascismo io ero già attiva nelle organizzazioni della Resistenza e quando venne il momento della lotta armata io allora, che ero operaia nella fabbrica per candele d'aerei « Baroncini », situata alle Roveri, abbandonai il lavoro e così fece pure mio fratello Sandro (Thomas) per passare all'organizzazione partigiana. Mio fratello andò coi primi partigiani nel Veneto e io divenni staffetta. Mio compito fu quello di assicurare i collegamenti fra il centro del partito comunista e le varie « basi ». Il lavoro era difficile e molto rischioso.
Cominciai con l'incarico dei collegamenti fra Umberto e Vittorio Ghini e la « base » di via del Piombo; da qui io smistavo materiale in un laboratorio fotografico di via Saragozza, in un magazzino di un imbianchino a Porta Galliera, nell'officina di un vulcanizzatore in via Mazzini e un altro posto ancora. Capii in tempo di essere stata riconosciuta da un milite e allora fui trasferita prima a Forlì e Forlimpopoli, poi a Parma. Qui fui arrestata, in seguito a delazione, nella base partigiana di Vicolo Santa Maria. Con me venne arrestata anche una giovane partigiana iugoslava, Julka Deskovic, che era in attesa di un figlio.
Nel carcere parmense di San Francesco fummo interrogate, per quindici giorni, alla maniera fascista: prima con le catene ai polsi, poi fummo torturate con un ferro rovente, poi mi sdraiarono sul pavimento con i polsi e le caviglie legate a croce contro i piedi di un tavolo e un cane lupo sempre attorno, minaccioso. E giù pugni, calci, bastonate. Le SS dicevano: « Tu Julka, tu Luisa kaput » e invece ci mandarono a Verona dopo un processo durato pochi minuti, compresa l'arringa di difesa pronunciata da un ufficiale delle SS, con tutta la milizia armata attorno, ci condannarono a trent'anni di galera, precisando però che dovevamo essere inviate al lavoro.
Si cominciò al campo di Gries, presso Bolzano, una vera anticamera della morte. Il comandante, gridò: « Toechter einer Huendinnen! » (figlie di cagne) e ci consegnò le tute con due diagonali nere incrociate sul petto e sulla schiena. Una notte fummo fatte uscire tutte per l'appello generale. Poi ci caricarono sui carri bestiame fra urla e pianti. Io mi unii a Julka e Clara, una giovanissima staffetta di Argenta. Dieci giorni di viaggio, nel sudiciume e fra i primi morti, senza nemmeno un po' d'acqua o di pane. Ad Innsbruck facemmo una breve fermata in stazione. Gridavamo: « Brot, Wasser »! (pane, acqua) ed i tedeschi risposero dirigendo contro le graticciate dei violenti getti con gli idranti. Poi ancora avanti fino a quando ci trovammo dentro al campo di concentramento di Ravensbrueck, il « Frau-Konzentration Lager » (di qui passeranno 130 mila donne di tutta Europa, delle quali 90 mila verranno uccise).
Nel campo di Ravensbrueck il lavoro forzato consisteva nel taglio dei boschi, nella costruzione di officine sotterranee e di rifugi antiaerei. Lavoravamo come bestie e per cibo dovevamo accontentarci di foglie, radici e torsoli di granoturco. Non ci fu mai permesso di fare un bagno. La nostra pelle era repellente ed eravamo tutte malate, ma alla visita medica assurda che ci facevano non bisognava dimostrare nulla altrimenti si finiva subito nei forni crematori. Nel campo trovai la famiglia Baroncini di Bologna, quasi al completo. Adelchi, il capofamiglia, era a Mauthausen dove morirà nel « castello delle cavie »; la madre era moribonda nella « cuccia »; le figlie Lina, Nella e Jole rimarranno ancora per poco insieme perché Jole, malata, verrà portata via e non si è mai saputo dove.
Le donne sovietiche furono straordinarie: nel campo di sterminio riuscirono ad organizzare persino la celebrazione del 7 novembre, ventisettesimo anniversario della Rivoluzione socialista. Fecero un « dolce » con briciole di pane e noccioline, bucce di patate, foglioline di abete. Verso il Natale del 1944, Julka ebbe una bimba e la chiamò Svoboda, che nella sua lingua voleva dire libertà. In febbraio undici pargoletti morirono di freddo, soffocati negli stracci luridi: fra questi Svoboda. Julka riuscì a non impazzire. Poi i nazisti asfissiarono tutti i bimbi che erano nel campo, assieme agli zingari deportati. Tutte le mattine, nel campo, i nazisti facevano l'appello generale: se una sola di noi mancava, anche se risultava morta o moribonda, allora chiamavano fuori dal mucchio venti, cento, una volta anche seicento numeri, per il massacro. Mandavano i cani contro le condannate a morte perché le azzannassero, poi le uccidevano o nei forni crematori, o mediante docce d'acqua bollente, oppure le gassavano. Più volte anch'io ho partecipato a quella tremenda lotteria.
Ricordo che una volta riuscii a comprare, con una buccia di patata, un pezzette di panno per coprirmi il petto. Era molto freddo e noi eravamo coperte appena di qualche straccio. Ricordo che dagli alberi cadevano dei grandi ghiaccioli e qualche deportata fu colpita e morì in quel modo. Alla mattina, alle tre e mezzo, c'era la sveglia e tutti fuori per l'appello. La « kapò » vide che mi coprivo il petto con un pezzo di panno e urlando mi unì alla « Strafkolonne » (colonna di punizione). Riuscii a salvarmi per l'intervento di una « kapò » russa, che convinse la tedesca a non insistere.
Poco dopo la metà di febbraio iniziò la marcia della morte. Nessuno sapeva dove si era diretti, nessuno sapeva niente. La colonna era di trentamila donne, cinque per cinque, vestite solo con un sacco di carta da cemento e zoccoli di legno ai piedi, e anche scalze e nude. La neve si aggrumava sotto i piedi e raddoppiava la nostra fatica. Era un corteo di spettri, sotto la pioggia e la tormenta. Le « Hauserin », che erano le « kapò » tedesche, lavoravano di staffile fino alla erano trainate su carretti dalle deportate, facevano da accompagnamento, finendo sull'istante chi cadeva. I bambini tedeschi tiravano sassate e urlavano insulti: cosa hanno insegnato loro? Avanti giorno e notte, sotto la -pioggia e nel gelo. I cani lupo azzannavano le ossa delle gambe, e nell'oscurità correvano abbaiando attorno alla colonna quando si riposava. Ed il mattino dopo di nuovo avanti, sempre senza sapere dove.
Clara, la staffetta di Argenta, mi sosteneva. Ora eravamo in Cecoslovacchia. Ai lati della strada notiamo qualche mucchietto di patate; ma chi si china, debole com'è, rischiava di cadere. E allora i tedeschi uccidevano. All'uscita da un bosco Clara mi disse: « Là in fondo c'è Praga! » Cominciammo ad accorgerci che le «Hauserin» erano sparite e che non c'era più nemmeno la scorta. Il cannone sparava vicino: si vedevano fumo e fiamme. Le sovietiche passarono in testa: avevano capito che poco oltre c'era l'Armata rossa.
Fummo ricoverate in ospedale e curate. Vidi che anche Clara era salva. Julka invece, non ce l'aveva fatta: sfinita e distrutta morì poco dopo nella infermeria di Ravensbrueck, dove i medici sovietici l'avevano portata nel tentativo di salvarla. In trecento, forse meno, eravamo vive. Fra di noi nessuna francese ce l'aveva fatta. Ma nessuna di noi, sopravvissute, potrà mai liberarsi dall'incubo di quei giorni.

 BACK
BACK

