Baroncini Nella - 2
Vai alla scheda biografica di
Testimonianza di Nella Baroncini, da: Luciano Bergonzini, La Resistenza a Bologna. Testimonianze e documenti, Bologna, ISB 1980, vol. V, p. 796
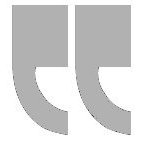 Fin dall'inizio della guerra di liberazione la casa dove abitavo, in via Rimesse 25, a Bologna, si trasformò in una piccola sede dove si riproducevano e distribuivano materiali di propaganda antifascista. Mio padre, che era operaio nell'officina « OARE », mia madre, le mie due sorelle Lina e Jole ed io eravamo impiegate e tutte, al termine del lavoro, ci dedicavamo all'organizzazione partigiana in diretto contatto con i fratelli Ghini, che assai spesso erano a casa nostra. Io ero la più giovane, avevo 18 anni, ma sentivo, al pari delle altre mie sorelle, l'impegno per il lavoro che ero ogni giorno chiamata a fare. Ricordo che in casa avevamo alcune macchine da scrivere, un ciclostile e molto materiale di propaganda partigiana che veniva prelevato e diffuso nella città e nella provincia. Spesso la Lina andava a Imola, in bicicletta, col materiale clandestino, ed io e l'altra mia sorella a Casalecchio e altre località.
Fin dall'inizio della guerra di liberazione la casa dove abitavo, in via Rimesse 25, a Bologna, si trasformò in una piccola sede dove si riproducevano e distribuivano materiali di propaganda antifascista. Mio padre, che era operaio nell'officina « OARE », mia madre, le mie due sorelle Lina e Jole ed io eravamo impiegate e tutte, al termine del lavoro, ci dedicavamo all'organizzazione partigiana in diretto contatto con i fratelli Ghini, che assai spesso erano a casa nostra. Io ero la più giovane, avevo 18 anni, ma sentivo, al pari delle altre mie sorelle, l'impegno per il lavoro che ero ogni giorno chiamata a fare. Ricordo che in casa avevamo alcune macchine da scrivere, un ciclostile e molto materiale di propaganda partigiana che veniva prelevato e diffuso nella città e nella provincia. Spesso la Lina andava a Imola, in bicicletta, col materiale clandestino, ed io e l'altra mia sorella a Casalecchio e altre località.
Non durò molto, però. Il 24 febbraio 1944 mio padre fu prelevato dai tedeschi in officina; mia madre, le mie sorelle ed io fummo arrestate in casa poco prima delle nove del mattino. Trovarono tutto e non ci fu possibilità di salvezza. Finimmo parte nel carcere di San Giovanni in Monte, parte al comando delle SS in viale Risorgimento e ci trovammo tutti uniti, i primi di maggio, nel campo di concentramento di Fossoli di Carpi dove restammo tre mesi. Poi mio padre fu portato nell'orribile castello di Hartheim, vicino a Mauthausen e lì è finito, straziato dalle torture. Il castello di Hartheim era chiamato il castello delle cavie perché i prigionieri vi erano trattenuti per mostruosi esperimenti sui loro corpi: nessuno vi è mai uscito vivo e solo i carnefici nazisti sanno esattamente cosa vi fosse e si faceva là dentro. Noi donne fummo tutte spedite nel campo di concentramento di Ravensbrùck (il Frau-Konzentration Lager), dove arrivammo il 6 agosto, dopoquattro giorni di viaggio in carro bestiame.
Non ci volle molto tempo a capire la realtà: tutt'attorno vedemmo subito masse di donne di ogni età, ridotte a pelle e ossa. Ci vennero incontro, rischiando botte e frustate, credendo che avessimo qualche pezzo di pane nelle tasche. Ci dissero di mangiare tutto in fretta perché ci avrebbero preso ogni cosa. Ci fecero la doccia, poi ci denudarono tutte, ci passarono in rassegna, poi ci diedero due stracci per coprirci un po' e ci misero nelle baracche e ci numerarono; io avevo il numero 49553. Dormivamo in castelletti di legno a tre piani e in uno spazio di 60-70 centimetri dovevamo starci in due, una dai piedi e una dalla testa, con appena un po' di paglia marcia per materasso. Quando si interruppero le mestruazioni cominciarono a formarsi delle piaghe purulenti nella pelle e a gonfiarsi le gambe e anche la faccia.
Il campo era comandato dalle « Hauserin », il corrispondente femminile di SS: erano violente e crudeli, più degli uomini, molto di più: non ho mai visto nei loro volti un segno di pietà, anche di fronte ai casi più commoventi, come quello disperato, di una donna che non ce la fa ad alzarsi da terra.
A sorvegliarci c'erano le «Kapo», le «Lagerpolizei»; erano criminali, o asociali e si distinguevano da un triangolo nero, mentre il nostro era rosso. Molte andavano a lavorare alla «Siemens», in fabbrica; altre — ed era il nostro caso — lavoravano nelle foreste, al taglio del legname. La sveglia era alle tre e mezza di notte e, dopo il lungo rito dell'appello, si andava al lavoro fino alle otto di sera. Come cibo ci davano, a mezzogiorno, un mestolo di brodo di rape, una sottilissima fetta di pane nero e alla sera quasi niente: quando andava bene c'era una patata bollita. Ricordo che, purtroppo, si finiva a fare a pugni per avere la più grande.
Non so come sia potuto accadere, ma un giorno si vide nel campo qualche giubbino e qualche pezzo di maglia: il prezzo per averlo era quella miserabile razione di pane nero. Ci ammalavamo tutte. Non ce la facevamo a resistere a restare in piedi, a volte anche tre ore, per l'appello della mattina con 18 gradi sotto zero: anche i capelli si gelavano. La mamma la portavano fuori a braccia. Dopo una settimana morì, ormai tutta consumata, nella sua cuccetta. La vidi la notte prima della morte: era tranquilla, non mi riconobbe nemmeno. Non mi crederete, ma in quelle condizioni, mi sono sentita soddisfatta quando l'ho vista morta: almeno non era finita ammucchiata nei carri del forno crematorio.
Il martirio continuava. Chi, per una causa qualsiasi, non ce la faceva a lavorare, veniva subito avviata ai forni crematori che funzionavano giorno e notte e il fumo saliva sempre, senza interruzione. C'era solo la speranza di vedere arrivare per miracolo i soldati russi o americani. Poi una lunga colonna di donne fu fatta partire dal campo. Fra queste mia sorella Lina. Io e Jole restammo a Ravensbriick. Il 4 marzo presero la Jole e la portarono fuori. Non l'ho più vista: è certamente finita nei forni crematori. Rimanemmo in poche, tutte malate, appena vive. Ci dissero che eravamo già state destinate ai forni crematori e non c'era che da aspettare il turno, ormai vicinissimo: non volevano lasciare testimoni. E invece, una mattina, sentii un gran trambusto di fuori e infine arrivarono i russi. Io e Julka, una mia compagna partigiana jugoslava, eravamo ridotte a un punto tale che per scendere uno scalino alto due centimetri, allo scopo di andare all'esterno a vedere la libertà, fummo costrette a sostenerci ad una grondaia. Era il 30 aprile 1945.
Appena fuori vedemmo le detenute slave coi fazzoletti rossi e proprio io non capivo come avessero fatto a procurarseli e tenerli nascosti. Alzavano i fazzoletti rossi sopra i loro scheletri, sopra i loro crani che erano come quelli della morte, rivestiti appena da una sottilissima pelle ancora viva. Anch'io dovevo essere ridotta così, una trentina di chili, al massimo. Ma almeno coi miei occhi non mi vedevo. I sovietici cercarono di salvarci: ci nutrirono con gradualità, con minestre leggere e cibi dolci. Io mi sono salvata. Julka no: non ce l'ha fatta. Malgrado tutto fosse finito è stata costretta a morire. A casa trovai Lina e fu una grande gioia. Ma ormai la nostra famiglia era distrutta: papa, mamma e Jole avevano finito la loro vita nell'inferno nazista.

 BACK
BACK


