Franchini Carlo
Carlo Franchini, Ritorno da Mauthausen; da: Il ritorno a casa. Testimonianze di battaglia e di prigionia della Seconda guerra mondiale e di profughi rifugiati a San Giovanni in Persiceto - Comune di San Giovanni in Persiceto, 25 aprile 1989.
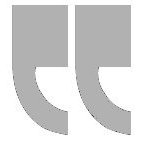 Apprendemmo la notizia dell'avvenuto armistizio la sera dell'8 settembre 1943. Ero caporalmaggiore e facevo parte del reparto radio telegrafisti al servizio degli Allievi ufficiali dell'Accademia di Modena che in quel periodo si trovavano alla Santona (Pavullo) per il «campo estivo». Eravamo circa 800 allievi e 40 militari dei servizi.
Apprendemmo la notizia dell'avvenuto armistizio la sera dell'8 settembre 1943. Ero caporalmaggiore e facevo parte del reparto radio telegrafisti al servizio degli Allievi ufficiali dell'Accademia di Modena che in quel periodo si trovavano alla Santona (Pavullo) per il «campo estivo». Eravamo circa 800 allievi e 40 militari dei servizi.
All'annuncio, il comando dispose che si rimanesse tutti fermi ai propri posti in attesa di ordini. Dopo 4-5 giorni però ancora nulla si sapeva. Aumentò così l'incertezza e a questo punto ognuno cominciò a pensare e a decidere per proprio conto con lo scopo principale di tornare a casa, così come feci anch'io.
Trascorsi l'inverno a casa e nella primavera del 1944 aderii al movimento partigiano entrando a far parte di una squadra SAP, operante nella nostra zona, con lo pseudonimo di «William».
Il 7 dicembre a Borgata Città i nazifascisti fecero un rastrellamento. Fui arrestato assieme ai miei due fratelli Emilio (classe 1918) e Alberto (classe 1920) e ad altri 4 partigiani della Borgata: Armando Ferranti, Alfredo Vecchi, Mario Serra e Guido Serra. Fummo portati tutti sette al carcere di Persiceto e due giorni dopo al Comando della Gestapo in via Santa Chiara a Bologna dove subimmo interrogatori accompagnati dagli usuali «trattamenti» che le SS riservavano ai resistenti prigionieri politici.
Il 12 dicembre venimmo trasferiti al carcere di S. Giovanni in Monte e il 22 successivo dovemmo partire tutti in autocolonna verso Bolzano, assieme ai rastrellati di Amola e di Anzola. Il primo trattamento nel campo di Bolzano fu quello di raparci tutti a zero e chiuderci in una baracca senza mai poter uscire.
La sera del 6 gennaio 1945 ci caricarono sui vagoni bestiame di un lungo convoglio: destinazione Mauthausen. Rimanemmo 5 notti e 4 giorni rinchiusi in quel vagone; ci diedero da mangiare una sola volta quando rimanemmo fermi per qualche ora in una stazione isolata, non grande, e per terra c'era la neve. Nel mio carro eravamo in 65 prigionieri, nessuno poteva scendere per riposare: al massimo e a turno, solo una ventina potevano sedersi. All'interno dovevamo fare tutto, compresi i bisogni corporali e c'era un tanfo insopportabile; la paglia marcita, il freddo, la fame e la sete. Questa era terribile. Per avere un po' di sollievo, per quietare l'arsura della gola, della lingua ingrossata, a turno leccavamo la brina che si formava sui grossi bulloni di ferro all'interno dei carri.
Quando distribuirono l'unico cibo, ogni due avevamo a disposizione un pezzetto di pane nero durissimo ed una scatoletta di carne di cui conservammo i vuoti. Poi unimmo l'una all'altra diverse cinture da pantaloni e pezzi di corda; all'estremità legammo una o due scatolette vuote, le facemmo passare oltre le sbarre e i reticolati delle piccole finestre in alto e le calammo tentando di raccogliere della neve mentre il convoglio era in corsa. A volte riuscivamo, ma spesso si raccoglievano sassi e cose ancor più brutte. Riuscivamo comunque a bagnarci la bocca ed era già molto, perché le labbra stavano gonfiandosi e si spaccavano provocando un immenso dolore.
Arrivammo a Mauthausen la mattina presto dell'11 gennaio; finalmente aprirono le porte e smontammo: lasciavamo il fetore del carro e con l'aria gelida, ma pura, sembrò tornasse la vita. Quindi raggiungemmo il campo che era sistemato su di una collinetta a tre chilometri dalla stazione. Ci misero incolonnati tra l'alto muro del recinto e il capannone dove erano le docce. Qui, tredici per volta, ci facevano spogliare e lasciare tutti i nostri vestiti. Ci rivestirono con altra roba che al solo vederla era facile immaginare chi l'aveva portata prima di noi. Ci mandarono fuori e rimanemmo lì fermi al freddo, con mezza gamba di neve, fino a quando fu completato il gruppo da mandare in baracca: era un freddo spaventoso. Finalmente ci fecero entrare in una stanza dove c'erano già altri prigionieri arrivati prima di noi; ci diedero da mangiare una «sboba» con dentro pastina dolce dal sapore rivoltante. Quasi tutti la rifiutammo e, a loro richiesta, la demmo ai vecchi prigionieri i quali ci dissero: domani la mangerete e sarà peggiore! Infatti da quel giorno mai più abbiamo visto pastina nella «sboba» e ci abituammo, per forza, a mangiarla. Dopo alcuni giorni ci diedero un nuovo numero di matricola.
I giorni di permanenza in quella baracca erano tutti una tragedia: non si dormiva più nei castelli di legno ma su dei pagliericci stesi in terra con cinque di noi sopra ad ognuno e in senso contrario per poterci stare tutti: quando uno si muoveva faceva male agli altri, ginocchiate e gomitate si susseguivano colpendoci uno con l'altro. Se la notte era stata rumorosa e capitava quasi sempre, alle 4 del mattino ci facevano alzare e dovevamo rimanere sull'attenti parecchie ore davanti alla baracca. Qualcuno per la stanchezza, per l'abbattimento fisico e morale, per il freddo, non resisteva e sveniva. Lo gettavano su un mucchio di neve e quando tornava in sè, di nuovo in fila. Questa era la vita del campo riservata ai prigionieri politici di Mauthausen.
Nei primi giorni di febbraio ci portarono giù a Gusen II, un sottocampo di Mauthausen chiamato «di lavoro», peggiore di quello di prima. Ci facevano alzare alle 4 del mattino per essere a lavorare alle sei: si facevano 12 ore di turno in fabbrica e poi si ritornava al campo. L' officina era scavata sotto la montagna; si lavorava alle strutture esterne degli aerei da caccia del tipo Messerschmitt. Ci caricavano su un trenino che ci portava direttamente all'interno della fabbrica. Si viaggiava, stipati fino all'inverosimile, a passo d'uomo affiancati, a terra, dalle SS con grosse pile elettriche e parecchi cani lupo addestrati. Inoltre i sorveglianti erano muniti del famigerato «gumma», specie di manganello di gomma durissima con dentro fili di rame, con il quale ci bastonavano per sveltire il riempimento dei vagoni. Inoltre, al rientro, a completamento della giornata c'era l'appello nella platz il che significava restare immobili sull'attenti al freddo come già era avvenuto alla mattina prima della partenza per il lavoro.
Passarono così tre mesi tremendi durante i quali molti morirono di stenti, di malnutrizione e di botte. Dei sette rastrellati di Borgata Città, solo io sono sopravvissuto. Avevo perso anche i fratelli: Emilio era stato ucciso dopo pochi giorni l'arrivo a Mauthausen quando si accorsero che, essendo mutilato di guerra a un braccio, non era idoneo al lavoro; Alberto invece, in seguito al forte deperimento organico, fu ricoverato all'infermeria e dopo tre giorni, non essendo più valido per il lavoro, fu assegnato al blocco della eliminazione dove fu ucciso quando mancava solo una decina di giorni all'arrivo degli alleati.
Finalmente arrivò la liberazione. Il 3 maggio 1945 venne sospeso il lavoro. Si era sparsa la voce che Hitler era morto. Per due giorni non ci portarono nemmeno quel po' di brodaglia con le patate marce di sempre. Il 5 maggio arrivarono le truppe alleate le quali cercavano di tenerci uniti al Campo Gusen 1 per farci fare un periodo di «quarantena » per curarci e farci riprendere forza pian piano. Ma tanta era la voglia di tornare a casa che non seguimmo il saggio invito e in un gruppetto di 9 ci incamminammo a piedi verso l'Italia.
Arrivammo nei pressi del Danubio e, avvicinandosi la sera e non avendo nulla da mangiare, raccogliemmo una bella quantità di lumache avviandoci poi verso una casa di campagna che trovammo già piena di ex deportati che cercavano ogni cosa da mangiare. Ci arrangiammo anche noi. Catturammo una gallina e trovammo dei vasetti di carne d'oca sotto grasso e un po' di farina.
Attraversato il Danubio su un ponte rabberciato alla meglio, arrivammo a Linz. Ci rifugiammo in un grande capannone dove trovammo due russi con i quali scambiammo un po' di farina con orzo. Cotta la gallina cucinammo nel brodo l'orzo e poi mangiammo tutto, comprese le lumache che avevamo raccolto, e così la notte fummo tutti colpiti da gravi dolori addominali. Non eravamo più abituati a mangiare molto. Per fortuna la mattina tutto passò e potemmo incamminarci di nuovo e dopo una sosta di due giorni in uno scantinato di un vecchio fabbricato bombardato di Linz, riprendemmo il cammino. Appena usciti dalla città trovammo un cavallo al pascolo; lo prendemmo caricandolo di tutte le nostre povere cose e andammo in cerca di un biroccio qualsiasi. Giunti a un casolare vedemmo diversi «fiacre» e alle due donne che lo abitavano ne chiedemmo uno.
Si rifiutarono ma noi, pressati dalla necessità di poterci a turno riposare salendo sulla carrozza, prendemmo il più piccolo fiacre, gli attaccammo il cavallo apprestandoci a partire. Proprio in quel momento arrivò una pattuglia della M.P. americana e ci ordinò di restituire tutto alle due donne. Dietro le nostre insistenze, e resisi conto che a piedi non potevamo proseguire, cercarono di convincere le due donne a lasciarci il fiacre. Ma loro ostinatamente si rifiutavano, anche quando gli americani si offrirono di pagarlo. A questo punto i M.P. spazientiti ci autorizzarono a partire con cavallo e carrozza invitandoci a non dire a nessuno di questa loro autorizzazione.
Felici «come pasque», riattaccammo il cavallo e salimmo in carrozza; ma il cavallo non voleva tirare e cominciò a fare salti. Uno di noi smontò e prese in mano la briglia: il cavallo si mosse e girammo così per otto o nove giorni.
Naturalmente non avevamo biada né fieno e davamo a quella povera bestia ciò che riuscivamo a raccogliere: di certo non era dieta adatta e sufficiente poiché l'animale non andava più e tutte le volte che c'era una piccola salita dovevamo scendere e spingere su anche lui.
Arrivammo a un posto di blocco americano, la strada passava solo di lì e non si poteva procedere. Scegliemmo di abbandonare carro e cavallo; li offrimmo a un contadino e proseguimmo attraversando la montagna per i sentieri scansando così il posto di blocco. Tornammo sulla strada e giungemmo a un campo di raccolta per militari italiani ex prigionieri. Ci accolsero bene e ci fecero tante feste; lasciammo tre compagni che non ce la facevano più. Sentendoci parlare in dialetto bolognese, si aggregarono a noi due di Casalecchio che avevano un solido biroccio con sacchetti di zucchero e riso e due bei cavalli. Noi, da parte nostra, avevamo un «papiro» che valeva come «lasciapassare» per sette persone. Ce lo fecero gli americani a Linz, era ormai scaduto ma per le pattuglie andava bene perché c'era scritto «...provenienti da Mauthausen». Essendo in otto uno, a turno, stava nascosto sotto i sacchi.
Partimmo così con due cavalli e un carro e ci fermammo alla «stanga» del Brennero. Gli americani ci scambiarono per banditi e stizziti e imbestialiti volevano metterci in prigione; disperati ricominciammo a piangere mostrando i papiri; un po' si commossero ma ci presero tutto e ci riportarono indietro a Innsbruck, dove restammo sei giorni insieme a sbandati di ogni genere: soldati, internati, volontari del lavoro in Germania, politici, con cimici mai viste di quella grandezza. Finalmente fummo inviati alla Croce Rossa di Bolzano e di qui, in autocarro, a Verona nella caserma dove si faceva la «quarantena» e lì avremmo dovuto rimanere fino a che non ci avessero puliti e curati. Qui il nostro gruppo di bolognesi si disperse: tutti tagliarono la corda per correre subito verso casa. Io rimasi con Osvaldo Corazza e Adelio Stanghellini. Con mezzi di fortuna arrivammo a Isola della Scala dove fummo rifocillati dalle suore di un convento. La sera stessa andammo in un parco del paese dove c'era un'autocolonna in partenza per Modena. Dopo forti insistenze riuscimmo a farci caricare nelle cabine delle autobotti incolonnate e il 25 maggio arrivammo a Modena. Qui ci lasciammo: Corazza e Stanghellini proseguirono per Bologna mentre io trovai subito un autocarro, guidato da un autista di colore, che mi portò a Ponte Samoggia, sulla via Emilia.
Rimasto per la prima volta solo e ormai vicinissimo a casa, stranamente cessò tutta la fretta di arrivare. Ero tormentato da un pensiero che mi martellava in testa: eravamo partiti in sette e ora tornavo solo! Come e cosa potevo rispondere alla mia e alle altre povere famiglie private così atrocemente dei loro cari? Mentre camminavo ho rivissuto tutta quanta la tragedia che si era consumata in quei maledetti «lager». Piangevo e mi accorsi che il passo era lento; la fretta che mi aveva incalzato negli ultimi venti giorni era scomparsa. Un'altra dolorosa prova mi attendeva. Il mio «ritorno» non fu certamente felice!

 BACK
BACK

